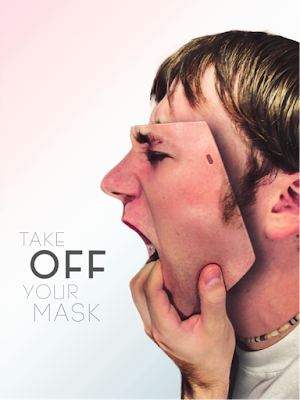"Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera"? Non certo il 54% della popolazione, che secondo le stime sarebbe in qualche modo afflitto dal fenomeno delle allergie primaverili (e non solo).
Al ciclico alternarsi delle stagioni corrisponde il susseguirsi dei diversi periodi di fioritura delle piante. Ecco allora che invisibili nubi di polline si riversano nell'atmosfera, diffondendosi anche a diversi chilometri di distanza dalla sorgente per depositarsi un po' ovunque, anche sulle mucose congiuntivali, nasali e delle vie aeree. Se le persone sono sensibilizzate alle proteine allergeniche liberate dai pollini, reagiscono con caratteristici sintomi clinici, fra cui:
-Congiuntivite
allergica: un intenso prurito, lacrimazione e fotofobia, con concomitante
iperemia congiuntivale ed edema a carico della congiuntiva palpebrale, spesso
associato a rinite
-Rinite allergica,
che implica:
a. Starnuti a
salve
b. Rinorrea acquosa
(ovvero naso che cola)
c. Congestione e
prurito nasale: talvolta tale sgradevole sensazione si espande fino a
raggiungere il palato, la laringe e gli orecchi. Gli individui allergici
possono altresì accusare anosmia (non sentono gli odori) e cefalea frontale
dovuta all'edema della mucosa che ostruisce i seni paranasali
d. Esigenza di
sputare e sensazione di corpo estraneo in gola
-Asma bronchiale
allergico: i sintomi associati sono tosse e dispnea (cioè difficoltà
respiratoria).
Le allergie
respiratorie possono essere determinate da una vasta gamma di sostanze dette
allergeni. Di seguito, ne cito i più ricorrenti.
-Betulacee e
corilacee: sono tra le prime piante a fiorire, tra gennaio e inizio aprile; tra
di esse vi sono la betulla, il nocciolo e l'ontano.
-Graminacee: la comparsa dei pollini si registra tra aprile e giugno, con un "colpo di coda" verso settembre. Hanno tutte caratteristiche sovrapponibili, tranne l'erba canina, la quale va eventualmente testata singolarmente.

-Parietaria: fiorisce da maggio a luglio, con una ripresa a settembre e ottobre. Ha caratteristiche di allergene perenne in alcune regioni del Sud Italia

-Olivo: il periodo di fioritura è da maggio a giugno. Diffuso sulle coste italiane nonché nella zona del lago di Garda.
-Acari: il
Dermatophagoides Pteronyssinus dà origine al più potente allergene che causa
l'asma. Si adattano bene alle abitazioni e dimorano soprattutto nei letti e nei
tappeti, nutrendosi delle scaglie di pelle umana derivanti dalla fisiologica
desquamazione. Le loro feci hanno dimensioni intorno ai 20 millesimi di
millimetro e sono quindi suscettibili di essere inalate in profondità dal naso
e nei polmoni.
-Epiteli animali:
sono fra le prime cause di reazioni allergiche. Perché si scateni il fenomeno
non è nemmeno necessaria la presenza dell'animale, in quanto gli allergeni sono
presenti nell'aria e nella polvere di casa.
-Muffe: le spore
di Cladosporium Herbarum raggiungono valori elevati anche in primavera-estate
e la muffa colonizza le sostanze vegetali, in particolare l'erba. Sono
rintracciabili anche sulla frutta, negli umidificatori, nei filtri dei
condizionatori nonché nelle macchie di umidità sui muri.
Fra i criteri
diagnostici del "male di
stagione" si annoverano i seguenti:
-Prevalente
comparsa tra gli 8 e i 40 anni
-Anamnesi
familiare frequentemente positiva
-Pregresse
manifestazioni di eczema atopico (specie in età infantile)
-Stagionalità
nell'insorgenza dei sintomi
-Positività ai
test cutanei con allergeni pollinici
-Possibile
riscontro di eosinofilia ematica
-Rast (ricerca
nel sangue degli anticorpi antiallergeni) positivo.
La prima forma di
terapia rimane sempre la prevenzione ambientale tramite bonifiche, piccoli
accorgimenti giornalieri o misure per l'allontanamento dell'allergene (per gli
allergici agli acari si sconsiglia il contatto lavorativo o domestico con
ambienti polverosi e si raccomanda l'uso di purificatori d'aria; per gli
allergici ai pollini si consiglia di evitare i luoghi aperti nelle stagioni
pericolose e soprattutto nelle giornate ventose).
Vediamo ora gli
effetti dell'inalazione di allergeni sul meccanismo vocale, e come
controllarli.
Le allergie
tendono a portare ad edema ed eritema diffuso a carico del rivestimento
epiteliale delle pliche vocali nonché della mucosa di rivestimento dell'intero
tratto vocale. La propriocezione ne risulta drammaticamente compromessa, ragion
per cui giunge difficile controllare la fonazione e la risonanza nel parlato e
soprattutto nel canto. Il rigonfiamento delle pliche vocali produce un suono
rauco, a volte sovrapponibile percettivamente a quanto si osserva in soggetti
affetti da laringite. La congestione delle cavità di risonanza contribuisce a
sua volta ad alterare i parametri percettivi del suono, sia all'orecchio dell'ascoltatore
che dell'emittente. Nel tentativo di proteggere i tessuti dall'allergene
irritante, il corpo produrrà - molto probabilmente - muco dalle caratteristiche
più viscose. Tale compromissione dell'apparato pneumofonatorio predispone alle
lesioni cordali, in quanto favorisce sforzi eccessivi e compensazioni
chiaramente controproducenti.
In base a uno
studio di Konig e Wyke, la disfonia nei pazienti con rinite allergica potrebbe
essere innescata dall'attivazione di riflessi rino-laringei dovuti a fibre
vasomotrici e secretrici di tipo simpatico e parasimpatico presenti nella
mucosa laringea e nel muscolo vocale (Konig W.F. and Von Leden H., The
peripheral nervous system of the human larynx. II. The thyroarytenoid
(vocalis) muscle. Arch Otolaryngol, 1961. 74: p. 153-163. Wyke B., Neurological
Mechanisms in spasticity: a brief review of some current concepts.
Physiotherapy, 1976. 62(10): p. 316-319).
Stando alla
spiegazione di Sant'Ambrogio et al., invece, la disfonia sarebbe da correlare
alla presenza di recettori specifici nelle coane nasali i quali, registrando
valori di pressione negativa, provocherebbero in via riflessa l'aumento
dell'attività del muscolo cricoaritenoideo posteriore (muscolo abduttore delle
pliche vocali). (Sant'Ambrogio, G. et al., Laryngeal receptors
responding to transmural pressure, airflow and local muscle activity. Respir
Physiol, 1983. 54(3): p. 317-330).
Proseguirò ora
con l'enumerazione di alcuni rimedi e soluzioni, raccomandando come sempre di
evitare l'automedicazione e di rivolgersi sempre ad una personalità medica
competente.
-Consultare quanto
prima un allergologo: l'individuazione delle cause non è sempre semplice. Un
test cutaneo o un esame del sangue positivi possono non essere sufficienti per
una diagnosi oggettiva. E' bene avvalersi dell'esperienza di medici specialisti
che, sulla base di un'attenta anamnesi, di un accurato esame obiettivo, e
talora con test allergologici specifici, possano individuare i fattori
responsabili ed impostare la strategia terapeutica più corretta, compresa una
spirometria per un'eventuale diagnosi di asma bronchiale.
-Far presente al
personale medico di riferimento che hanno a che fare con un professionista
della voce: alcuni (oserei dire, molti) dei medicinali prescritti tendono a
seccare - anche notevolmente - la laringe e l'intero tratto vocale (cfr la
parte finale di questo post).
-Indossa una
mascherina: se le reazioni allergiche sono scatenate dal contatto con erba,
pollini, polvere e muffe, risulta imperativo indossare una maschera protettiva
quando si eseguono attività "a rischio", quali tagliare l'erba, la
pulizia della casa, etc.
-Mantenere la
propria abitazione ed il proprio domicilio accuratamente puliti, passando
regolarmente l'aspirapolvere (ricordate la mascherina!) magari dotato di filtro
HEPA.
-Cambiare
debitamente i filtri dell'aria (mensilmente, se possibile).
-Usare - se
necessario - un umidificatore nei mesi invernali.
-Dormire con il
capo elevato: tale posizione migliora il drenaggio dei seni paranasali. La
posizione supina della testa, al contrario, favorisce il ristagno del muco
all'interno del seno mascellare e nel retro della faringe, andando
conseguentemente ad irritare le mucose di rivestimento nonché dando vita ad aree
umide che attirano i batteri. Il ristagno di muco al'interno di un seno
paranasale predispone altresì all'infezione dello stesso.
-Evitare di
starnutire producendo un suono vocale: cercare di produrre, in fase di
starnuto, un suono "ch" sordo (ovvero senza vibrazione cordale e
conseguente suono udibile) in modo da non traumatizzare la superficie cordale.
-Bere acqua calda
o the alle erbe con limone, per un'efficace azione anticongestionante.
-Se necessario
ricorrere (tramite prescrizione medica, preferibilmente, oppure richiedendo
medicinali "da banco") a mucolitici.
-Evitare
l'assunzione di alcolici: essi sono vasodilatatori e stimolano la produzione di
muco, peggiorando la congestione nasale.
-Eseguire
quotidianamente dei lavaggi nasali con acqua (termale) o una soluzione salina:
per istruzioni su come fare (in inglese): http://www.webmd.com/allergies/ss/slideshow-nasal-irrigation
Un discorso un
po' più articolato merita la trattazione della terapia farmacologica
normalmente prescritta dagli pneumologi. Essa comprende, di routine, gli
antistaminici, i cromoni, gli antileucotrieni, in particolare i cortisonici
locali e sistemici, a cui si aggiungono eventualmente i broncodilatatori. La
maggioranza di tali rimedi farmacologici ha proprietà seccanti e tende ad
ispessire la secrezione mucosa. Tale effetto potrebbe anche essere
desiderabile, laddove un utente della voce accusi secrezione mucosa
eccessivamente abbondante in seguito a reazione allergica, ma spesso è
controproducente e mette in serio rischio l'incolumità degli organi fonatori.
E' consigliabile, per chi usa la voce a fini professionali, iniziare (se
effettivamente è necessario un trattamento farmacologico) con uno spray corticosteroideo
topico nasale: tali rimedi, infatti, riescono spesso a bloccare la reazione
allergica con effetti meno seccanti sulla laringe e la faringe, e risultano
sicuri e più efficaci degli antistaminici nel controllo dei sintomi. Solo
successivamente, in caso di insuccesso o di gravità sintomatica, si può pensare
di aggiungere un antistaminico al bisogno, a basse dosi. Se si deve sostenere
una performance vocale in orario serale, sarebbe comunque auspicabile che
l'eventuale antistaminico fosse assunto il mattino, lontano dall'esecuzione
vocale. Sembra che - al vaglio dei benefici e degli effetti collaterali - la
Loratadina (nome commerciale: Clarityn) sia uno degli antistaminici migliori
per i professionisti della voce. Se dovesse risultare troppo "blando",
ve ne sono comunque altri che il medico di fiducia saprà certamente
consigliare. Un po' di "sperimentazione" (sempre e solo sotto
controllo medico) permetterà verosimilmente di identificare il prodotto
migliore per ogni singolo individuo, valutando benefici, effetti collaterali e
compatibilità con lo stile di vita e la professione del soggetto. Attenzione
alla quantità di pseudoefedrina contenuta negli antistaminici: una
concentrazione troppo elevata (120-140 mg) avrà proprietà seccanti eccessive e
potrebbe causare persino insonnia, ipertensione e aumento del battito cardiaco.
Per coloro che non vogliano fare uso di corticosteroidi, nonostante essi risultino
assolutamente sicuri se usati al giusto dosaggio e all'interno di tempistiche
ragionevoli (alcuni spray nasali possono provocare effetto rebound se usati
eccessivamente a lungo, nonché "dipendenza"), esistono in commercio
anche degli spray "naturali" che contengono Capsaicina, i quali
risultano sicuri ed efficaci. In casi più preoccupanti, la terapia
dell'eziologia allergica può anche prevedere la desensibilizzazione (il
vaccino, ovvero l'immunoterapia specifica), che si basa sulla somministrazione
di dosi crescenti dell'allergene o degli allergeni coinvolti fino ad indurre una
tolleranza clinica dell'organismo verso l'allergene stesso.
Per chi canta o
usa la voce per lavoro, l'allergia è un vero e proprio flagello che però, se
accuratamente identificato, può essere generalmente tenuto sotto controllo. Le
manifestazioni cliniche sono estremamente variabili per gravità e durata.
Purtroppo, attendere non serve: quando c'è un'allergia respiratoria, raramente
si verifica una risoluzione spontanea dei disturbi. Nella maggior parte dei
casi, anzi, il quadro clinico tende alla cronicizzazione o addirittura al
peggioramento. Per questo motivo si raccomanda un'esatta e precoce diagnosi a
cui faccia seguito un'appropriata terapia.